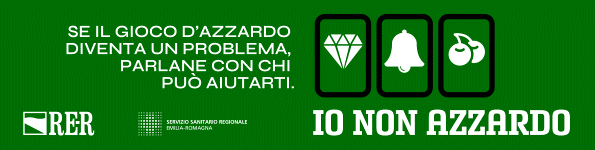REGGIO EMILIA – Sara Piccinini, da senior coordinator a direttrice della prestigiosa Collezione Maramotti: certo si tratta del riconoscimento di competenza e passione; ma Sara quando è stata folgorata dalla passione per l’arte?
“Non so se si possa parlare di folgorazione, piuttosto di una relazione naturale di familiarità che ha preso forma negli anni, di quotidiano intreccio con la vita. La libreria di casa era piena di testi e riviste d’arte e fin da piccola i miei genitori mi hanno portata in giro con loro per mostre e musei. Sono cresciuta in un’atmosfera ricca di stimoli, in questo senso. Ma penso di aver messo a fuoco che davvero avrei voluto lavorare in questo campo negli anni dell’università. L’arte contemporanea mi affascinava moltissimo, perché pur restando ineffabile si infilava negli interstizi della realtà e la scardinava. Niente sembrava scontato. Ricordo ad esempio una mostra al Mart di Rovereto, i primi incontri con Ontani in forma di centauro e con un autoritratto ibrido di Matthew Barney, orecchie animali ed elegante giacca bianca. Lo stesso Matthew Barney che poi ho ritrovato scolpito in onice messicana da un altro artista, Barry X Ball, qui in Collezione”.
Il XXI secolo si apre con una rivoluzione al femminile in campo artistico; infatti alla testa di musei, gallerie, accademie, ma anche nel campo della critica, sono sempre di più le donne a rivestire posizioni chiave e a far prevalere il loro sguardo. Si potrebbe dire che si tratta del frutto, anche in campo artistico, di quella che lo storico Eric Hobsbawn definisce nel suo “Il secolo breve” , dedicato agli avvenimenti principali del 900, l’unica rivoluzione riuscita, anche se non compiuta, quella femminista. Ti senti parte di questa rimonta?
“Credo che la presenza delle donne, in tutti i campi, sia qualcosa per cui impegnarsi ogni giorno. Questo percorso non è certamente concluso, lo sarà solo quando non avremo nemmeno più bisogno di parlarne, perché il genere non sarà più una discriminante. Mi sembra che le artiste stiano trovando spazio sempre maggiore negli ultimi anni. Anche in Collezione circa la metà dei progetti presentati dall’apertura hanno riguardato artiste, e la prossima mostra sarà dedicata a Ruby Onyinyechi Amanze, nata nel 1982 in Nigeria e di base a Philadelphia.
Ma se guardiamo al passato, anche limitandoci al ‘900, non sono molte coloro che sono riuscite a far sentire la propria voce, rispetto ai colleghi uomini. Un paio di anni fa abbiamo presentato un progetto di Helen Cammock (vincitrice del Max Mara Art Prize for Women e in seguito anche del Turner Prize) che partiva proprio da questa necessità: riscoprire voci femminili nascoste, rievocare il potere della testimonianza e del lamento, dal Seicento a oggi, attraverso storie ed esperienze diverse, da rifugiate ad artiste, da religiose ad attiviste e partigiane”.
“Rehang Maramotti” è un progetto che hai seguito da vicino. Si tratta del riallestimento di 10 sale della collezione, una piccola rivoluzione. Ti chiedo di spiegarla , ma vorrei anche sapere : pensi che il femminile , alla testa di musei e gallerie, sia anche generativo di profondi cambiamenti ?Un esempio per tutti: la rivoluzione museologica di Cristina Collu, Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte moderna e contemporanea di Roma, effettuata accostando opere di periodi e generi diversi.
“La premessa necessaria per risponderti è che il ruolo che ricopro non è quello di una direttrice artistica o di una curatrice. Non siamo un museo pubblico, siamo una collezione privata aperta al pubblico (gratuitamente), in cui la famiglia dei collezionisti è fortemente coinvolta nelle scelte progettuali, anche perché le opere che presentiamo in mostra entrano a far parte della raccolta. Gli interessi e le scelte personali della famiglia Maramotti sono il punto da cui iniziamo a ragionare su progetti e mostre. Anche per Rehang (2019), l’input per il riallestimento di una serie di sale in permanente ci è arrivato dai collezionisti; come organizzarlo, quali progetti includere, quali opere è stato frutto di una discussione interna e condivisa tra il nostro staff, i collezionisti e gli artisti stessi. Credo che una particolarità significativa del nostro approccio sia proprio questa, cerchiamo di mettere gli artisti al centro di riflessioni e decisioni in cui spesso non sono coinvolti, per creare un progetto in cui le opere siano pienamente rappresentative della loro ricerca. Rehang è nato dal desiderio di condividere il work in progress di dieci anni di progetti, di mostrare una traccia della crescita più recente della Collezione dal 2008 al 2017. Abbiamo dovuto fare una selezione, naturalmente, e abbiamo deciso di creare delle piccole mostre monografiche: dieci sale per dieci artisti. Alcuni di loro sono tornati per riadattare i loro progetti agli spazi e tutti erano presenti all’inaugurazione, a testimonianza del legame ancora vivo con questo luogo. Questo allestimento è tuttora visibile al secondo piano della Collezione, ma non escludo che in futuro possa essere nuovamente aggiornato”.
A dire il vero la Collezione Maramotti pare dalla nascita vocata al femminile. Marina Dacci ne è stata la prima direttrice, ma un altro segno che va nello stesso indirizzo è il “Max Mara Art Prize for Women”, in collaborazione con Whitechapel Gallery. In una tua recente intervista, parlando del premio, ricordi che, covid permettendo, Emma Talbot, la vincitrice dell’8ª edizione, dovrebbe iniziare i suoi 6 mesi di residenza in Italia in aprile. Ci puoi dire se esiste già una idea progettuale sulla quale lavorerà la Talbot?
“Emma Talbot ha vinto il Max Mara Art Prize for Women con una proposta di progetto articolata e ambiziosa incentrata su tematiche profonde e molto contemporanee: il potere, la governance, il rapporto tra l’essere umano e la natura, la rappresentazione della donna. In particolare il suo punto di partenza è stato il dipinto di Klimt “Le tre età della donna” (conservato proprio alla GNAM di Roma che hai citato prima), in particolare la figura della donna anziana che vi è rappresentata, che Talbot intende animare, sottrarre a una dimensione di vergogna, scherno e impotenza e rendere un soggetto capace, oggi, di imprese simili alle dodici fatiche di Ercole. L’idea del progetto ruota quindi intorno a questa sorta di nuova eroina che possiede il potenziale per ricostruire la società contemporanea. Nel corso della residenza in Italia, Talbot avrà l’opportunità di fare ricerca artistica, classica, letteraria, ma anche di sperimentare e approfondire l’artigianato tessile, la tecnica jacquard (tra l’altro proprio a Reggio Emilia, in collaborazione con la Modateca Deanna) e anche di entrare in contatto con realtà che si occupano di permacultura.
Talbot è la vincitrice dell’ottava edizione del Max Mara Art Prize, che è nato nel 2005 da una collaborazione fra Max Mara e Whitechapel Gallery, ancor prima che la Collezione esistesse, ed è uno dei segni dello stretto rapporto che l’azienda ha sempre intrattenuto con il mondo dell’arte”.

“”The fountais of Za’atari” l’opera pubblica installata, grazie all’acquisizione della Collezione Maramotti, nel 2019 nel Parco Cervi in centro a Reggio Emilia, è parte di articolato progetto di un’altra donna, Margherita Moscardini che riflette sulle questioni della precarietà abitativa, su migrazioni e appartenenza. L’artista ha fatto una mappatura delle fontane al centro dei cortili del campo profughi di Za’atari in Giordania, divenuto ormai una città e la grande lastra di marmo posata sul piedistallo a forma di decagono ne è una sorta di topografia. Un’opera non facile. Pensi partendo dalla tua esperienza di questi anni, che esista uno specifico femminile nella scelta delle tematiche che ispirano l’espressione artistica delle donne?
“Penso che esistano delle qualità e delle sensibilità che possono essere riferite alla sfera femminile, indipendentemente dal genere di chi le possiede e dell’opera d’arte che ne è in qualche modo informata. Il progetto di Margherita Moscardini sul campo di Za’atari, di cui parli, si è sviluppato grazie al coinvolgimento di moltissimi soggetti con cui l’artista è riuscita a confrontarsi. È permeato da una forte dimensione collaborativa – il libro del progetto, che sarà pubblicato a brevissimo con Quodlibet, lo mostra con chiarezza. E questa dimensione si ritrova anche, ad esempio, nel lavoro di Kaarina Kaikkonen, o in quello di Claudia Losi, di cui pure abbiamo presentato una mostra nel 2016 e di cui stiamo continuando a sostenere il lavoro (la Collezione è partner culturale del progetto con cui Losi ha vinto l’ultima edizione dell’Italian Council). Ma anche il lavoro di Krištof Kintera o di Evgeny Antufiev è attraversato da questo tipo di pratiche a più mani, a più voci. Oppure, per spostare il discorso sulla pittura, che ancora oggi è il focus principale della Collezione: ogni artista che si occupa di questo linguaggio ha delle sensibilità proprie, individuali. Nel 2014 abbiamo organizzato “Ritratto di donne”, una mostra che metteva a confronto opere di Chantal Joffe e Alessandra Ariatti, due artiste che hanno entrambe concentrato la loro ricerca nel ritratto, soprattutto di persone a loro vicine, conosciute, e soprattutto di soggetti femminili. Ma, pur partendo da presupposti molto simili, i loro esiti formali erano e sono completamente diversi”.
Natalia Maramotti
Chi è Sara Piccinini
Sara Piccinini ha studiato semiotica all’Università di Bologna dal 2002 al 2005, trascorrendo anche un periodo di Erasmus all’Université Libre di Bruxelles nel 2005. Nel 2006 ha svolto un periodo di internship presso la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e si è poi perfezionata con un corso di marketing e comunicazione dell’arte al Sotheby’s Institute of Art di New York nel 2012 e con corsi di social media marketing, rivolti soprattutto a gallerie e professionisti dell’arte, della Fondazione Fitzcarraldo di Torino e del Node Center for Curatorial Studies di Berlino.
La Collezione Maramotti di Reggio Emilia, della quale è la 37enne nuova direttrice, la vede al suo interno fin dalla sua data di apertura nel 2007. Ha ricoperto diversi ruoli in Collezione fin occupandosi di comunicazione, progetti espositivi ed editoriali e residenze. Da gennaio 2018 è stata Coordinatrice e da allora ha assunto piena responsabilità dell’organizzazione e della programmazione delle principali attività interne ed esterne della Collezione, in collaborazione con musei ed istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.