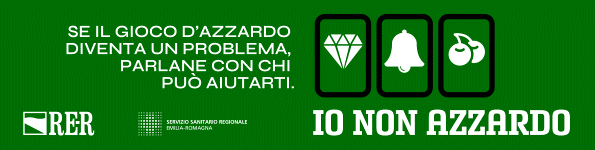REGGIO EMILIA – Partiamo da una constatazione; stare nel mondo dell’arte del passato significa stare nel cuore del maschilismo. Infatti se sfogliamo le pagine dei manuali di storia dell’arte, oppure percorriamo i corridoi dei musei, incontriamo pochissime opere di artiste del passato. Perché di donne non ce ne sono state?
“La scarsa presenza di donne nell’arte antica riflette, in generale, più un problema sociale che strettamente storico artistico, dato dalla subalterna condizione femminile nel passato. Le poche artiste del Cinquecento e del Seicento erano delle figure eccezionali in una società incentrata sugli uomini, che vedeva le donne relegate per lo più all’interno delle mura domestiche o dei conventi. Molte delle artiste di quell’epoca erano, non per caso, “figlie d’arte”: la fiamminga Catharina van Hemessen, le bolognesi Lavinia Fontana e Elisabetta Sirani, la monaca piemontese Orsola Maddalena Caccia e, nel contesto romano, Artemisia Gentileschi e la oggi più nota Plautilla Bricci (portata alla ribalta di recente grazie al bel romanzo storico “L’Architettrice” di Melania Mazzucco) furono aiutate dal contesto, perché ebbero l’opportunità di formarsi in ambito familiare e di acquisire competenze che non era lecito apprendere altrove, perché considerate “sconvenienti”, come lo studio dell’anatomia. Le donne non avevano accesso alle Accademie (fu eccezionale il caso della veneziana Rosalba Carriera, nota soprattutto per i suoi straordinari ritratti a pastello, ammessa all’Accademia di San Luca a Roma nel 1705) e non potevano, sempre per ragioni di decoro, andare a bottega da un maestro. Singolare, nel Cinquecento, è la vicenda della nobile cremonese Sofonisba Anguissola che si formò, insieme ad una delle sue sorelle (ma anche le altre quattro sono attestate come pittrici), nella bottega del pittore Bernardino Campi. Questo sovvertimento delle regole era avvenuto però con il consenso del padre Amilcare, che agiva come un impresario. Non era possibile alle donne relazionarsi con eventuali committenti e acquirenti, dovevano fare affidamento a una figura maschile per i contatti con l’esterno, per le trattative e per firmare i contratti, una condotta troppo libera sarebbe stata considerata immorale. Con queste premesse, in molti casi la naturale inclinazione di una donna nei confronti dell’arte restava un passatempo: la pittura, la poesia o la musica erano doti tenute in grande considerazione nell’educazione di una giovane nobile o di buona famiglia, ma difficilmente potevano diventare una professione. Tra non molti giorni aprirà a Palazzo Reale a Milano una mostra intitolata “Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600”, credo sarà una buona occasione per avere una visione d’insieme.
Nel 2019 come conservatrice della collezione del Credem ti sei occupata del dossier della mostra “Di mano d’una donna” dedicata alla Sacra Famiglia con i Santi Caterina, Elisabetta e Giovannino di Lavinia Fontana. Lavinia Fontana, come Elisabetta Sirani, è un’emiliana, nasce a Bologna e viene avviata alla pittura dal padre. Se volessimo tracciare brevemente una tua storia dell’arte al femminile quali sarebbero le protagoniste?
“Senz’altro Lavinia Fontana mi è molto cara, anche come esempio di donna realizzata professionalmente e nel suo rapporto con il marito, che la supportava nel lavoro firmando i contratti e seguendo l’allestimento delle opere pubbliche. Lavinia, verosimilmente anche grazie ad un carattere mite e ad un marito consapevole e in grado di valorizzare le qualità della moglie, riuscì ad essere sposa, madre (ebbe ben 11 figli, ma solo tre erano ancora vivi a inizio Seicento, a causa dell’alto tasso di mortalità infantile) e una celebre pittrice. Un equilibrio molto difficile da raggiungere ai suoi tempi e, bisogna ammetterlo, anche nei nostri.
Artemisia mi attrae per la sua personalità più indipendente e inquieta. Ricordo che lessi nei primi anni di Università gli atti del processo per lo stupro di cui fu vittima, nel 1611, da parte di Agostino Tassi: il racconto mi turbò e al contempo mi fece riflettere sulla forza interiore di quella giovane donna, le cui doti sul fronte artistico erano innegabili.
Una figura diametralmente opposta, sempre tra fine Cinquecento e il pieno Seicento, è la monaca Orsola Maddalena Caccia, della quale mi sono occupata anche come specialista: tra le mura del monastero seppe dare vita ad una fiorente bottega di pittura sacra, ma il genere che la caratterizza maggiormente, nel quale fu capace di offrire un contributo più originale, è senz’altro quello della natura morta.
Proseguendo in ordine temporale, nella mia personale storia dell’arte al femminile si approda a fine Ottocento con Camille Claudel, una scultrice francese, allieva e poi compagna di Auguste Rodin, secondo me di grande qualità e degna di maggiore considerazione, soprattutto per le sculture in bronzo. L’ho conosciuta negli anni del liceo grazie ad una bella mostra monografica a Palazzo Magnani.
Sempre nello stesso periodo mi avvicinai anche alla messicana Frida Kahlo, ora resa celebre da numerose mostre: durante un’estate al mare lessi le sue lettere, piene di passione, di voglia di vivere nonostante le molte sofferenze per il suo corpo fragile. I suoi intensi autoritratti sono notissimi, ma per me una delle sue opere più intriganti è Quel che l’acqua mi ha dato (o Ciò che ho visto nell’acqua) del 1938: attraverso la visione dei suoi piedi con le unghie laccate di rosso immersi nell’acqua in una vasca da bagno l’artista ripercorre in figure piccole e brulicanti la sua vita e anche i suoi traumi.
Negli anni dell’università mi colpì molto una mostra organizzata a Milano di fotografie di Francesca Woodman, una giovane che pose fine ai suoi giorni nel 1981, a soli 22 anni. Le sue foto in bianco e nero, di grande qualità anche sul fronte tecnico, sono per la maggior parte autoscatti, oggi diremmo selfie: sembrano immagini senza tempo, hanno una forza e un lirismo che trovo straordinari.
Un’artista tuttora vivente, che ho conosciuto di persona alcuni anni fa e che mi affascina per la sua fede e la sua forza spirituale è Chiara Vigo, l’ultimo maestro di bisso marino del Mediterraneo, un filato preziosissimo del colore dell’oro ricavato da un mollusco, la pinna nobilis, che non uccide, ma restituisce all’acqua, nel rispetto della natura. Il bisso e le sue opere tessute non si possono vendere né comprare: sono eseguite su un telaio antico, il bisso è tessuto anche con le unghie e i modelli (leoni, pavoncelle, palmette) sono tramandati di generazione in generazione. Acquisire la maestria, che le ha insegnato sua nonna, ha comportato il giuramento di vivere per proteggere e servire il mare e di vivere di offerte. Ha fondato il Museo del Bisso a Sant’Antioco in Sardegna, che porta avanti non senza difficoltà, dove accoglie gratuitamente le persone che vogliono farle visita.
Dirigi una collezione privata, importante della nostra città, quella del Credito Emiliano che apre le sue porte annualmente ai visitatori. Ci sono opere che attraversano la storia e autori importanti anche a livello locale, uno per tutti, Luca da Reggio. Com’è il rapporto tra il passato e le nuove acquisizioni?
“La collezione d’arte antica di Credem segue criteri ben precisi per le acquisizioni: dalla metà degli anni settanta la banca ha iniziato a formare una collezione di dipinti antichi di maestri emiliani o attivi in Emilia tra l’inizio del Cinquecento e la fine del Settecento, con una particolare predilezione per la pittura barocca, la stagione d’oro dell’arte bolognese. Le nuove acquisizioni rispettano ancora oggi questo criterio. Il radicamento di Credem ad un preciso contesto storico-geografico ha infatti giocato a favore di un progetto culturale che si propone di riflettere la produzione artistica della città di Reggio Emilia e del più ampio contesto artistico regionale. I capolavori di Guido Reni, Lanfranco, Guercino, Cristoforo Munari, rendono conto della ricerca costante di dipinti di alta qualità. La collezione riflette senz’altro gli artisti attivi nelle chiese reggiane: solo per citarne alcune, le opere di Alessandro Tiarini, Leonello Spada e Luca da Reggio sono legate al santuario della Madonna della Ghiara, le tele di Camillo Procaccini e Bernardino Campi richiamano l’attività dei due maestri nella basilica di San Prospero. Non ti nascondo che l’acquisizione del dipinto di Lavinia Fontana, il primo dipinto di una pittrice ad entrare in collezione, per me è stata una grandissima soddisfazione sul fronte professionale e come donna”.
L’artista donna del passato più nota è senza dubbio Artemisia Gentileschi; la sua storia appassionata è oggetto di film e romanzi. Penso si possa dire che Artemisia nei suoi dipinti riflette i temi della condizione femminile, penso per esempio a Susanna e i vecchioni. Esistono molte opere dipinte da donne che rappresentano eroine della storia e della Bibbia, da Lucrezia a Giuditta, da Cleopatra a Maddalena, sembrano parlarci attraverso il pennello. Ti sei mai posta questa domanda?
“Probabilmente Artemisia Gentileschi è la pittrice oggi più conosciuta, complice la sua vita e le sue vicende personali così singolari. Credo si sia identificata senza difficoltà nella Susanna insidiata dai vecchioni… anche nella capacità di far fronte ad una situazione che avrebbe potuto compromettere la sua l’esistenza e che lei fu capace di gestire con lucidità e di volgere a suo favore. Ci sono senz’altro soggetti che sono stati più cari di altri alle artiste antiche, perché permettevano loro di identificarsi con le sante e le eroine da loro ritratte, ma erano sempre donne figlie del loro tempo e credo sia una forzatura voler applicare alle loro opere letture che sono troppo legate alla sensibilità attuale. Di grande rilievo, a mio parere, è che la loro volontà di essere riconosciute come donne colte e consapevoli delle loro capacità passasse spesso attraverso gli autoritratti: Sofonisba Anguissola e Lavinia Anguissola si ritrassero in diverse occasioni e Artemisia e Elisabetta Sirani si raffigurarono, in maniera programmatica, anche nelle vesti di Allegoria della Pittura“.
Scrive Jeremy Riefkin nel suo saggio “L’era dell’accesso”: “L’assorbimento della sfera culturale in quella economica segnala un cambiamento radicale nelle relazioni umane con conseguenze devastanti per la civiltà del futuro”. La sfida è l’integrazione strategica tra cultura e mercato il che porta a interrogarsi sul futuro delle professioni culturali, anche in termini di sviluppo di posti di lavoro. Bisognerebbe augurarsi che il futuro non riservi occupabilità solo per gli appassionati di materie STEM; dal tuo punto di vista la correlazione tra beni culturali e nuove tecnologie potrebbe essere la chiave di volta per una formazione, anche accademica, capace di assicurare occupabilità anche in campo umanistico?
“Le nuove tecnologie legate all’arte, come la realtà aumentata, gli ambienti immersivi, i sistemi interattivi di fruizione possono aiutare ad avvicinare una parte del pubblico all’arte, a patto che questo non significhi perdere il rapporto “fisico”, con le opere. La capacità di dare vita a progetti di qualità sul piano multimediale necessita di competenze specifiche, quindi credo che corsi universitari legati alle nuove tecnologie possano portare alla creazione di nuove professionalità e opportunità di occupazione. Penso però che l’applicazione delle tecnologie non possa prescindere dalla una collaborazione con studiosi più “tradizionali”, che abbiano specifica e approfondita conoscenza dei contenuti, per trasmettere e divulgare le conoscenze in modo corretto. Gli studiosi dovranno fare sforzi per semplificare (che non significa banalizzare) alcuni concetti in modo da renderli più facilmente comprensibili, ma l’uso delle tecnologie senza un lavoro scientifico serio alle spalle rischia di creare progetti interattivi avvincenti sotto il profilo emozionale, ma deboli e fuorvianti sul fronte dei contenuti. Una collaborazione proficua credo possa essere vincente e di soddisfazione (anche per le opportunità lavorative) per le differenti professionalità messe in campo”.
E’ uscito di recente un tuo saggio, in un volume dedicato al ‘600 in Spagna, a Napoli, Genova e Milano, relativo all’Ultima Cena di Giulio Cesare Procaccini. C’è stato un tempo non lontano, poco meno di 100 anni fa, in cui il fascismo proibì alle donne l’insegnamento delle materie umanistiche, in particolare storia e filosofia. Nel secondo dopoguerra le donne hanno reagito alla oppressione e alle limitazioni della loro soggettività e hanno cambiato il mondo prima con l’emancipazionismo poi con il femminismo; ti senti parte di questa storia?
“Il saggio è uscito all’interno degli atti di un convegno che si è tenuto nel 2018 tra Torino e Genova, un’occasione molto proficua di confronto con altri studiosi, dove ho parlato di Giulio Cesare Procaccini, un pittore bolognese, ma “naturalizzato” milanese, del primo Seicento, in rapporto a Genova. Amo molto questo artista, gli ho dedicato quasi un decennio di lavoro tra il dottorato di ricerca e un libro monografico che ho pubblicato nel 2020 insieme a Hugh Brigstocke, uno studioso inglese. L’opera più importante eseguita da Procaccini per Genova è, appunto, l’Ultima Cena, un dipinto grandioso (circa 5 x 9 metri) che si trova nella chiesa della Santissima Annunziata del Vastato. Nella tela, eseguita nel 1618, il pittore offre una rilettura, soprattutto nella resa delle psicologie degli apostoli, del Cenacolo di Leonardo a Milano: un particolare è stato scelto, per la sua straordinaria qualità, come copertina del volume.
Per quanto riguarda il processo di emancipazione femminile negli studi umanistici, ma anche nelle carriere professionali in termini più generali, naturalmente il passaggio fondamentale del secondo dopoguerra è stata l’opportunità offerta alle donne di studiare e la conseguente capacità di comprendere con maggiore chiarezza la loro condizione e migliorarla. Oggi, almeno nel mondo Occidentale, la situazione è molto cambiata ed è più favorevole alle donne rispetto al passato, ma il processo sarà davvero terminato quando questi temi non saranno più oggetto di discussione, perché desueti e completamente superati. Se pensiamo che uno specifico obiettivo dell’Agenda ONU 2030 è dedicato a “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”, ci rendiamo conto di come le sfide aperte, non solo a livello globale, siano ancora molte. Nel mio campo, pensando al dopoguerra che hai richiamato, una grande figura è stata senza dubbio Palma Bucarelli. Volitiva ed elegante, è stata la prima donna in Italia a dirigere un museo pubblico, l’attuale Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma: seppe unire competenza e passione, fermezza e capacità di osare”.
Natalia Maramotti
Chi è Odette D’Albo
Odette D’Albo è un’altra giovane reggiana che si è dedicata all’arte. Laureata in storia dell’arte moderna nella Facoltà di lettere moderne presso l’Università di Bologna nel 2007, ha conseguito la laurea specialistica in storia dell’arte nel 2010 all’Università Cattolica di Milano. Borsista alla Fondazione Roberto Longhi di Firenze (2010- 2011), nel 2016 ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università Cattolica di Milano. In questi anni si è occupata di questioni legate prevalentemente alla cultura figurativa di area lombarda dal Cinquecento al Settecento e di storia del collezionismo. Suoi interventi sono apparsi sulle riviste «Arte Lombarda», «Paragone», «Nuovi Studi».
Ha curato il volume Giovanni Stefano e Giuseppe Montalto. Due pittori trevigliesi nella Lombardia barocca (Milano 2015) ed è autrice, insieme a Hugh Brigstocke, di Giulio Cesare Procaccini. Life and Work with a Catalogue of his Paintings (Torino 2020). Dal 2016 è curatrice delle collezioni d’arte del Credito Emiliano (Credem) a Reggio Emilia.