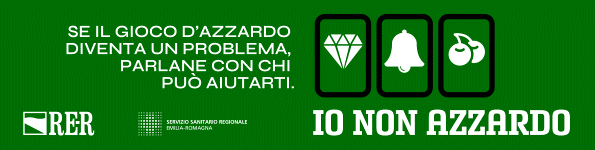PARMA – Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Puccini, solo per citarne alcuni, sono tutti uomini. L’assoluta apparente inesistenza di una capacità generativa delle donne nella musica, come in altri settori dell’arte, è certamente determinata dal ruolo subalterno che le donne hanno avuto nella storia. Un esempio per tutti, quello di Maria Anna, Nannerl, la sorella di Mozart. Ho letto che era talentuosa e si esibiva con lui da bambina nelle corti d’Europa, ma il padre Leopold decise di puntare sul figlio maschio.
Anna Maria Meo, tu non sei musicista ma musicologa, anche questa non è una carriera molto frequentata dalle donne. Com’è nata questa passione?
“E’ nata come è accaduto a tante bambine e bambini, grazie a due genitori illuminati che hanno creduto fosse fondamentale arricchire la mia formazione con un percorso formativo parallelo in ambito musicale. Non immaginavano che avrei sviluppato i miei orizzonti professionali in questo settore e chissà, se lo avessero saputo si sarebbero anche preoccupati, ma erano certi che si trattasse di una dimensione necessaria … e avevano ragione”.
Partendo dalla tua tesi di laurea sull’organizzazione musicale in Italia, riferita al nuovo ordinamento degli enti lirici, passando al tirocinio al Maggio Fiorentino, alla produzione di opere e l’organizzazione teatrale e musicale, al coordinamento di progetti di ricerca sul suono, mi sembra descrivano una predilezione anche se le tue esperienze sono davvero molto ecclettiche. Assumere il ruolo di direttrice del Regio di Parma, con il suo prestigio e la sua fama internazionale, è stato quindi un modo per dare spazio a questa predilezione liberando passione e creatività?
“La tesi dichiarava già il mio interesse per l’ambito gestionale, organizzativo e progettuale. Devo dirti che l’ecletticità cui fai riferimento effettivamente c’è e credo sia stata una grande opportunità per ampliare i miei orizzonti. Se il mio percorso professionale fosse nato e si fosse sviluppato esclusivamente nell’ambito delle istituzioni operistiche sarebbe stato molto meno stimolante e non avrei potuto riverberare sul mio incarico attuale un approccio gestionale e progettuale forse poco ‘ortodosso'”.
Mogli, figlie, sorelle, fidanzate: le protagoniste del melodramma romantico e poi verista nella maggioranza dei casi vivono nel fascio di luce proiettato dai protagonisti maschi. Sono vittime di intrighi, amanti appassionate, spesso votate al suicidio, sono donne perdute che muoiono per espiare i propri peccati. Si può dire che il melodramma ha avuto una funzione di rappresentazione dei valori e dei modelli culturali dell’epoca ed è stato specchio di una società patriarcale. Per una donna come te, che non dissimula la sua appartenenza di genere, come mi pare di poterti descrivere, qual è il rapporto con le protagoniste del melodramma?
“Credo che sia evidente che ci siano modelli culturali radicati che dobbiamo contribuire a scardinare. Le protagoniste del melodramma non rispecchiano più l’identità femminile attuale. I modelli della società sono profondamente cambiati ma sembra che una parte dell’universo maschile fatichi ad accettare il cambiamento e anzi lo rifiuti. Questi uomini non sono capaci di confrontarsi con una condizione di emancipazione culturale, sociale e professionale delle donne e reagiscono facendo pagare la loro inadeguatezza alle donne che trasformano in vittime”.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lo scorso anno il Teatro Regio, ai tempi di Anna Maria Meo, ha promosso la campagna “ Neanche per finta” e, prendendo spunto dalle storie delle eroine del melodramma vittime di violenze, stupri e assassini, ha richiamato l’attenzione della comunità sul fatto che le storie di violenza raccontate ed evocate in musica per finzione , purtroppo sono ancora oggetto della cronaca , quasi ogni giorno. Pensi che la cultura possa far prendere coscienza a bambini, ragazzi e uomini che loro stessi per primi devono impegnarsi perché questa guerra, non dichiarata ma permanente, che fa della relazione affettiva tra un uomo e una donna e della casa dove vivono il teatro pericoloso della sopraffazione, talvolta fino alla morte della donna, cessi definitivamente?
“Credo che le protagoniste, spesso drammaticamente sfortunate, ricordino ancora troppo da vicino donne di oggi, vittime di violenza, di soprusi e di una cultura maschilista ancora potentemente radicata dalla quale sembra non si riesca ad affrancarsi. Il Teatro Regio per il secondo anno consecutivo ha promosso una campagna di sensibilizzazione su questo tema: l’hashtag associato a questa campagna è #neancheperfinta e si ispira proprio alle figure femminili che nei libretti d’opera soccombono alla violenza di mariti, padri e fratelli violenti. E’ una campagna che si sviluppa nel corso di tutto l’anno e che vede testimonial molti degli artisti che si esibiscono in Teatro e culmina con alcune azioni simboliche proprio il 25 novembre, che è la giornata dedicata a questa campagna, come l’esposizione delle scarpe rosse sulle scale esterne del Teatro Regio la cui facciata viene illuminata di rosso”.
La tua designazione come Direttrice del Teatro Regio non è stata scevra di polemiche, come quasi sempre accade nel dibattito cittadino, che non si sottrae alla strumentalizzazione politica ad ogni latitudine. A distanza di 5 anni, anche solo numeri alla mano, mi pare si possa sostenere che la tua gestione è stata fortemente generativa e, almeno a mio parere, molto contraddistinta da attenzione alla relazione e alla creatività coraggiosa, che spesso distinguono l’agire delle donne; alludo alle esperienze che ti hanno visto portare la musica negli spazi del “margine”, carceri, quartieri popolari, ospedali, così come scommettere sui giovanissimi, creando una stagione teatrale per loro. Rivendichi questo tuo modo di essere come un talento di genere o pensi sia semplicemente un talento soggettivo?
“Francamente credo che chi guida una Istituzione sia chiamato a dare la propria impronta, la propria idea sul ruolo che questa Istituzione deve interpretare su un territorio. Questo vale forse a maggior ragione per un Teatro d’Opera la cui produzione vede al centro un genere musicale erroneamente percepito come “superato” e che invece rappresenta un patrimonio vitale al quale attingere per riverberare sul territorio, con particolare attenzione alle comunità e ai luoghi di maggiore fragilità, tutta la ricchezza che può sprigionare e che può contribuire a far percepire il senso di presidio culturale che queste Istituzioni devono avere. Credo anche che questa dimensione sia ancora più importante nella fase difficile che stiamo vivendo e lo sarà ancora di più quando dovremo curare i postumi di questa esperienza traumatica per ripartire. Ecco, forse in questo vedo un contributo di genere: l’attitudine al prendersi cura delle persone, dei progetti e in questo caso delle Istituzioni e delle comunità che le abitano. Credo che i secoli passati, durante i quali alla donna è stata affidata la cura, nel senso più nobile del termine, delle famiglie e della collettività, abbiano lasciato una traccia nel DNA che ci portiamo dietro e che in molti casi riusciamo a declinare nei contesti nei quali siamo chiamate ad agire”.
Ci siamo conosciute grazie a Parma Capitale della Cultura 2020 e alla intuizione politica, penso unica nel suo genere, che ha fatto della occasione di protagonismo di una città, quella di Parma, una opportunità generosa per promuovere un intero territorio , quello di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, cosicché si possa dire: 3 città una unica destinazione turistica. Parliamo quindi di turismo e di come tu abbia aperto le porte del Regio alle visite turistiche, con una modalità stabile, nonostante le esigenze di un teatro che deve effettuare allestimenti, prove. Anche in questa tua duttilità nel leggere il teatro come un luogo di bellezza architettonica e di narrazione della storia di una comunità, dal quale i visitatori non possono prescindere per comprendere il genius loci e il genius gentis della città che stanno conoscendo, penso ci sia molto del femminile accogliente e sfidante, tu che dici, ti riconosci in questa mia lettura?
“Si, mi riconosco abbastanza. Credo che abbiamo la possibilità di valorizzare al meglio anche la dimensione artistico-monumentale dei Teatri che sono luoghi in cui si sviluppano attività creative in contesti di incredibile fascino. Limitare la fruizione di questi luoghi ai momenti di spettacolo e agli spazi canonici ai quali di solito si può accedere, genererebbe un limite e farebbe torto a coloro che desiderano visitarli in momenti diversi, conoscerne meglio la storia e magari avere l’opportunità di accedere al back stage o a spazi “di lavoro” quando non impegnati dalle attività ordinarie. E’ un modo per far percepire la magia, la speciale alchimia che questi luoghi generano ed è anche un modo per far innamorare i visitatori e per renderli spettatori più consapevoli del grande privilegio di cui si gode quando si assiste a uno spettacolo in Teatri di così straordinaria bellezza”.
Natalia Maramotti