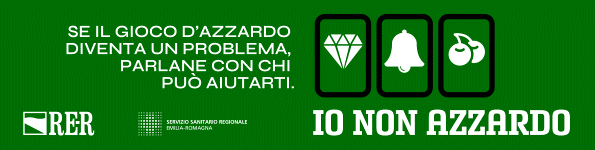REGGIO EMILIA – Elena Pulcini è una docente dell’Università di Firenze dove insegna Filosofia Sociale. Il suo palmares annovera tra l’altro un titolo di Nouveau Doctorat nel giugno 1991 presso l’Università di Paris II- Sorbonne Nouvelle di Parigi, il primo Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa” nel 2009 con il suo “La cura del mondo – Paura e responsabilità nell’età globale”; vanta una ricca produzione tra libri e articoli, molti sono tradotti nelle principali lingue europee.
Attenta al tema delle passioni e del soggetto moderno, focalizzandosi sul soggetto femminile , ha prodotto una filosofia della cura per l’età globale. E’ anche una delle voci, più interessanti e più consolidate, sulla cura come valore che scaturisce da un altro modo di sentire e vivere la relazione con l’altro, per diventare patrimonio non solo femminile ma universalmente umano.
E’ stata spesso ospite della città di Reggio Emilia , coinvolta dalla Amministrazione Comunale; da ultimo nell’evento “Europa- femminile singolare” tenutosi nella primavera del 2019.
***
Se si consultano i manuali di storia della filosofia in adozione nelle scuole superiori italiane si deduce che la filosofia non è stata un “affare per donne”. Come si è appassionata la ragazza Elena Pulcini a questo sapere?
“Sbarcata a Firenze dalla costa marchigiana per iscrivermi all’Università nel mitico ’68, non ho esitato a riconoscere nella filosofia il percorso più eccitante e rigoroso ad un tempo per comprendere e cambiare il mondo, insieme ai miei nuovi fiduciosi compagni, innamorati del futuro. Seminari su Marx e Freud, su Eros e civiltà di Marcuse e sulla Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkheimer diventarono il luogo costante di tessitura di idee e speranze collettive dai quali uscivamo per ritrovarci insieme attorno alla chitarra e alle note entusiasmanti di Across the Universe: senza smettere di discutere e appassionarsi, riconoscendosi reciprocamente come gli orgogliosi paladini di un’utopia a portata di mano. La filosofia offriva un approccio critico al reale che ho da allora portato con me, e non solo nella vita accademica, perché l’ho sempre concepita come una scienza di vita, soprattutto se capace di “contaminarsi” con altri saperi, come la psicoanalisi e l’antropologia, la sociologia e la letteratura. Allo stesso tempo, era un inesauribile tesoro di parole, concetti, immagini con cui sporgersi oltre la critica dell’esistente, per disegnare nuovi percorsi e prospettive. Da questo si può intuire che il mio rapporto d’amore con la filosofia non ha avuto sempre vita facile: ero una donna, una giovane donna che usciva dagli schemi di una disciplina accademica molto gelosa della sua astrattezza, e che per di più si lanciava in tematiche eretiche: ricordo oggi con un brivido la mia decisione ardita di lavorare su Rousseau e l’amore, e la reazione dei colleghi, lo sguardo opaco quando mi chiedevano cosa studiavo: “ah bene Rousseau…il Contratto sociale”? “No, per la verità, La Nuova Eloisa, testo straordinario per capire la concezione moderna dell’amore e del soggetto”… (cfr. Amour-passion e amore coniugale, Rousseau e l’origine di un conflitto moderno, Marsilio 1990). In fin dei conti, a pensarci bene, il prezzo che ho pagato non è stato poi così alto, se togliamo una lunga solitudine e un po’ di ritardo nella carriera accademica, ritardo relativo se pensiamo che il “soffitto di cristallo” è ancora oggi uno degli ostacoli, per le donne, alle cosiddette pari opportunità”.
In una intervista a Il Foglio, in fase pre-pandemica, era il 5 settembre 2019, spiegavi: “Se mi lasciassi sopraffare dal pessimismo, sarei tentata di aderire all’ammonimento heideggeriano, ma se vogliamo darci una speranza, la filosofia può effettivamente venire in nostro soccorso. Cosa intendevi dire?
“Mi riferivo alla celebre affermazione di Heidegger “Solo un Dio ci può salvare”, che allude anche all’inefficacia (e persino alla “morte”) della filosofia di fronte allo sradicamento dell’essere umano spodestato dal potere della tecnica. Senza poter entrare nel merito di questo grande tema, quello che vorrei suggerire di fronte alle sfide della contemporaneità è al contrario il valore, quanto mai attuale, della filosofia come allenamento al pensiero, come amore del sapere (come ci dice la sua stessa etimologia). Noi stiamo perdendo la capacità di pensare intesa nel senso di Hannah Arendt: quella perdita che ha fatto sì che il nazista Eichmann si rendesse “banalmente” colpevole dello sterminio degli ebrei e che oggi, più banalmente, ci rende vittime di un male postmoderno. Quale? Siamo vittime di una sorta di automatismo del fare che è sempre più cieco verso le sue conseguenze, ossessionati dalla ricerca di un benessere che si esaurisce nel qui ed ora e se ne infischia del futuro delle generazioni e del pianeta, rispondiamo alla seduzione effimera di un consumismo compulsivo e di un edonismo da quattro soldi che abbiamo l’ardire, come stiamo vedendo in questi mesi di pandemia, di rivendicare come pretesa di libertà. Viviamo in superficie, e perdiamo il contatto sia con le profondità emotive della nostra interiorità, sia con le altezze luminose della nostra mente. Inghiottiti dalla velocizzazione di esistenze convulse, non abbiamo più il tempo né la voglia di sostare sulle cose di cui finiamo per smarrire il senso e lo scopo. Abbiamo dunque un bisogno estremo di ricominciare a pensare e a sentire, per poter recuperare un fare capace di creatività, immaginazione, progetto. L’educazione, se presa sul serio, e l’arte, se resa più accessibile, potrebbero essere percorsi fecondi in questo senso”.
Della parola “cura”, con tutta la sua pericolosa ambiguità, si è impadronita di recente la politica italiana. Nel tuo “Il potere di unire-femminile, desiderio, cura” scritto 17 anni fa, fai una lettura molto convincente di come la cura può proiettarsi al di fuori del recinto del privato e del femminile per diventare un patrimonio universalmente umano. Credi che questo cambio di paradigma possa essere la rivoluzione della quale ha bisogno la politica, screditata e in sofferenza, basata su narcisismo e sopraffazione, potremmo dire su valori patriarcali?
“Certo, era inevitabile che soprattutto l’evento drammatico della pandemia, con il suo implacabile potere di far riaffiorare la nostra vulnerabilità, riportasse in auge una parola –cura/care- per lo più svalutata dalla nostra cosiddetta civiltà: svalutata in quanto, associata esclusivamente alle donne, al privato e agli spazi limitati della sfera intima, è sempre stata chiamata ad assolvere a quella “necessità” che ha il compito di sostenere e consentire il libero svolgersi dell’azione nella sfera pubblica, la quale è essenzialmente maschile. La cura dunque, almeno a partire dalla modernità (e da Rousseau) si configura come una sfera puramente affettiva e assistenziale che coincide con la nascita dell’immagine tutta coniugale e materna della donna. Con una doppia penalizzazione: sia della cura che delle donne, entrambe escluse dalla sfera sociale e politica. Non a caso è lo stesso pensiero delle donne che, a partire degli anni ‘80 (quando esce Con voce di donna di Carol Gilligan) ne ha proposto una rivalutazione, sottolineando la sua natura affettiva, relazionale, rispetto al soggetto individualistico e razionalistico del pensiero patriarcale. Questo non vuol dire ignorare i possibii risvolti negativi della cura, quando ri-diventa sacrificio (nel caso delle donne) o paternalismo (come nel caso di uno stato verso i cittadini), né vuol dire dimenticare che la relazione di cura può generare passioni negative, come l’insofferenza di chi si fa carico dell’altro o il risentimento di chi ne è oggetto e la subisce come un’umiliazione (ce lo ricordano le aberrazioni di cui sentiamo parlare all’interno di asili o case di riposo, o i danni psicologici prodotti da un materno apprensivo e fusionale). Ripensare la cura significa dunque saperne distillare le qualità costruttive per sottolineare l’importanza di un soggetto aperto all’alterità, consapevole del legame e incline alla cooperazione: valori dei quali conosciamo sempre di più le basi biologiche e universali, a partire dalla riscoperta dell’empatia, che va ben al di là delle differenze sessuali. Vuol dire dunque sottrarla all’identificazione col femminile, la famiglia, gli affetti per mostrarne le più ampie potenzialità: vale a dire la capacità di prestare attenzione, come direbbe Simone Weil, a ciò che ci circonda, dalle piccole alle grandi cose, di riconoscere ciò che è importante e di impegnarsi per preservarlo. La cura è alimentata da una disposizione affettiva, ma è anche impegno, prassi, costanza nell’azione: è preoccupazione e sollecitudine. Indubbiamente questa nuova “postura”, che prevede in primo luogo una metamorfosi del soggetto potrebbe rivoluzionare la sfera pubblica e il mondo della politica, motivato oggi sempre di più da un misero calcolo degli interessi e spesso reso cieco verso tutto ciò che va giusto un po’ oltre l’immediata e utilitaristica contingenza del presente. Appare insomma sempre più evidente che le nostre società democratiche hanno bisogno di cura, come aveva intuito già nell’800, uno dei più grandi teorici della democrazia, Alexis de Tocqueville, quando proponeva di “educare la democrazia”: che vuol dire essere consapevoli della sua preziosa fragilità, combatterne le potenziali e sempre endemiche patologie e valorizzarne gli aspetti emancipativi”.
Partiamo da un altro tuo libro “la cura del Mondo”, ne hai dissertato nel 2011 a Reggio Emilia con l’allora sindaco che mi aveva affidato l’originale delega alla cura della comunità. Ancora una volta il tuo pensiero è straordinariamente contemporaneo; nell’epoca della pandemia da Covid 19 si è diffuso il convincimento che non possiamo vivere come predatori della natura. Tu parli della paura come occasione per considerare la propria vulnerabilità e trasformarla in sollecitudine e cura. Pensi che sia un pensiero qualificabile come femminismo ambientalista?
“Grazie per questa domanda perché sono sempre più attenta e preoccupata della sfida ecologica e spesso mi imbatto in atteggiamenti ottusi e indifferenti, anche da parte di chi non te lo aspetteresti. Per me è talmente prioritaria che mi ha spinta per la prima volta nella mia vita a coinvolgermi anche nella politica istituzionale, accettando di candidarmi, alle elezioni europee, nei partiti ambientalisti. La sfida ecologica è una zona cieca, dove sembrano arenarsi anche le menti più intelligenti: in parte perché la nostra psiche non è in grado di concepire un pericolo così estremo come i potenziali effetti “catastrofici” del riscaldamento climatico e dell’erosione delle risorse naturali, e in parte, o forse soprattutto, perché non vogliamo rinunciare al nostro stile di vita e ai nostri privilegi. E dunque mettiamo in atto quel meccanismo di difesa che Freud chiamava diniego: in virtù del quale sappiamo bene quello che succede -e come potremmo non saperlo nell’epoca della comunicazione e dell’informazione?- e tuttavia impediamo che ciò che accade arrivi alla nostra emotività. Conosciamo ma non sentiamo. Questa diagnosi, che già proponevo ne La cura nel mondo, è oggi tristemente attuale, come vediamo anche dalle intollerabili derive caricaturali del cosiddetto “negazionismo” rispetto alla pandemia. Ma purtroppo, con buona pace dei signori del diniego, il Covid19 continua a mietere vittime e seminare morte, a sconvolgere le nostre vite, a minare l’illusione del nostro illimitato potere e la presunzione di uno scontato benessere. Stiamo facendo esperienza di una condizione che la nostra stessa civiltà tende da sempre a rimuovere: la vulnerabilità dell’umano. In questo senso ben venga la pandemia se ci scuote dalla nostra hybris e dalle nostre infantilistiche pretese di sovranità. Perché è la nostra stessa hybris che, spingendoci alla sistematica e dissennata violazione della natura, ci ha portati a questo punto. Pochi purtroppo sembrano ricordare che la pandemia è a sua volta un effetto, letale e globale, della nostra volontà di dominio: deforestazioni e inquinamento hanno finito, paradossalmente per renderci vittime, con l’ormai ben noto “salto di specie” (spillover), di un virus veicolato da un pipistrello! E ben venga persino la paura se è in grado di agire come la passione del limite che ci riporta alla consapovolezza delle nostra ineludibile vulnerabilità. Perché forse è solo un vulnus, una ferita, che può rompere le pareti fittizie del Truman show nel quale ci ostiniamo a voler vivere da compulsivi consumisti e da edonisti a buon mercato, e disarcionarci dalla nostra illusione di sovranità, rivelandoci la verità dell’umano: che è tale solo se riconosce le proprie responsabilità e prende in cura il mondo di cui fa parte, alleandosi -e non violandole- con le specie non umane, stabilendo, come dice Donna Haraway, delle “parentele” con le specie viventi. Tutto questo può trovare particolare risonanza nel femminismo? Possiamo parlare di un femminismo ambientalista? Forse sì, se pensiamo oltre che ad Haraway, a Vandana Shiva, ad Arundathi Roy e all’ecofemminismo. Tuttavia la voce delle donne, la voce collettiva delle donne, mi sembra ancora troppo debole su questo problema, come se le donne non riuscissero a trasmettere nella questione ecologica la stessa passione che mettono nella questione sociale e sessuale”.
Partiamo dall’effetto economico della pandemia: crollo del PIL mondiale, con indebolimento ulteriore delle moltitudini in povertà e rarefazione della c.d. classe media. Si sente dire: dobbiamo utilizzare questa crisi per ripensare il nostro modello di sviluppo. Io direi : dobbiamo ripartire dalla giustizia sociale. Nel tuo “Tra cura e giustizia- le passioni come risorsa sociale” ti chiedi quali passioni presiedano alla lotta contro l’ingiustizia. E’ un paradosso dire che una economia plasmata dalla cura dell’altro potrebbe essere la prospettiva per questo cambio di passo?
“Sì, questo è forse, insieme alla crisi sanitaria, l’aspetto che più fortemente tocca le persone. Siamo tutti preoccupati delle ricadute economiche della pandemia perché sappiamo bene quanto una crisi globale come quella che abbiamo già vissuto nel 2008, possa incidere sulle nostre vite. Siamo totalmente dipendenti da un modello di sviluppo che non può permettersi di spegnere le macchine, fermare la produzione, bloccare il consumo, e che funziona solo attraverso una sempre più accelerata dinamica acquisitiva: quella di un capitalismo predatorio sostenuto dalla logica implacabile di un neoliberalismo che ha eretto l’economico, il profitto, il denaro ad unico e imperante (dis)valore, e che deve ad ogni costo convincerci che “non ci sono alternative” (con quella formuletta insidiosa che ormai ben conosciamo: TINA/ “There Is No Alternative”). Eppure basterebbe ricordarsi di Adam Smith e di Max Weber -che avevano l’ardire di proporre un’alleanza tra economia ed etica- per sollevare qualche dubbio e sforzarsi di pensare (come non mancano di fare oggi economisti eretici e coraggiosi) altri e diversi modelli di sviluppo. Modelli non solo più attenti a disuguaglianze e povertà, oggi in scandaloso aumento nello scenario globale, ma anche frutto di una nuova consapevolezza: cioè del fatto che tutti, anche i più garantiti e persino i più ricchi, dovranno presto fare i conti con gli effetti perversi e incontrollabili di un capitalismo che, saccheggiando la natura, rischia di rendere il mondo insostenibile e invivibile. La pandemia è il primo segnale, tanto più allarmante quanto più globale, di questo pericolo: non possiamo non cogliere questo segnale, dobbiamo imparare della terribile esperienza che stiamo vivendo che è arrivato il momento, urgente e non rinviabile, di prendersi cura del mondo”.
Infine una domanda laconica: ti definiresti femminista?
“Direi di sì, ma non come marchio identitario, cioè come unica o prioritaria identità, e non in senso ideologico. Devo confessare che non ho avuto un rapporto facile col femminismo della prima stagione, quello della separazione e del conflitto col maschile, di cui pure riconoscevo il senso e il giusto valore eversivo, l’afflato emancipativo. Non solo per le rigidità ideologiche che non permettevano le ambivalenze e i dubbi, le esitazioni e i punti oscuri che per me non possono mancare nella ricerca verso la verità, se non vuole essere assertiva né definitiva; ma anche per una ragione più modesta e vitale ad un tempo, e cioè il desiderio di proteggere l’amore, la relazione d’amore, che mi ha vista forse più fortunata di tante mie compagne di percorso, colpite da un’esperienza col maschile irreparabile e devastante. Certo è che il femminismo che ho più condiviso e nel quale mi sono sentita riconosciuta è quello delle stagioni successive quando, oltre la lotta e la critica della cultura patriarcale, emerge il bisogno di parole positive come la cura e la responsabilità, che ci consentono di avventurarsi, almeno con l’immaginazione, verso scenari nuovi e alternativi; scenari dove trovano dimora valori rimossi come la gratuità e la bellezza, la reciprocità e la condivisione; e dove, sia pure attraverso una lotta che non può che essere interminabile, Eros riesca di volta in volta ad avere la meglio su Tanathos”.
Natalia Maramotti
Aggiornamento 11 aprile 2021
Covid, morta la filosofa Elena Pulcini: leggi l’ultima intervista