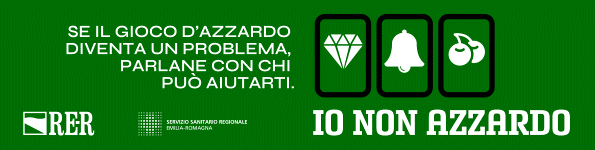REGGIO EMILIA – In una bella intervista realizzata, qualche anno fa, dall’istituto Parri per la Storia e la Memoria del 900 emerge che la tua formazione alla politica parte dalla realtà della scuola, dalla tua professione di insegnante di lettere nelle scuole superiori. Siamo negli anni 70: quanto ha inciso la contingenza storica sulla tua militanza?
“Quell’intervista era focalizzata specificamente su come gli avvenimenti legati al ’68 avevano inciso nella scuola e con quale partecipazione da parte mia. Tuttavia la mia formazione politica inizia negli anni precedenti, quelli dell’università in cui facevo parte della FUCI (Federazione Universitaria Cattolici Italiani) che, a Modena, aveva declinato l’impegno religioso legato alla dottrina sociale della Chiesa, con un forte interesse, perciò, alla presenza attiva nel contesto sociale e politico. Il circolo E. Vanoni e successivamente Il Portico furono i luoghi del mio apprendistato politico che trovò nella scuola e nel movimento degli insegnanti la palestra per esercitarsi in concreto. In quegli anni subito successivi al ’68 la mia militanza si affermò nella scuola superiore dove insegnavo sia approfondendo il problema della selezione (era stata pubblicata “Lettera a una professoressa”) che dialogando con il movimento degli studenti sulle richieste – assai contrastate dalla maggior parte degli insegnanti – di assemblee e gruppi di studio (al movimento si rispose, nel 74, con l’emanazione dei Decreti Delegati). Diciamo che facevo parte degli insegnanti “progressisti” tesi a dare un contributo di trasformazione e ammodernamento della scuola, ritenendo che la riforma della scuola media unica del 1962 non fosse compiuta. E contemporaneamente l’impegno militante mi portò a prendere parte a un doposcuola che ospitava bambini della scuola elementare con diverse carenze scolastiche, figli di immigrati meridionali, per contrastarne la selezione, cioè come si diceva, la bocciatura “di classe”. Come si vede, si intersecavano piani diversi centrati sulla scuola e le sue finalità, guidata da un’idea di emancipazione di quegli strati popolari che non possedevano il capitale culturale familiare di coloro che appartenevano alla classe borghese. Quel percorso mi portò subito dopo a iscrivermi alla CGIL scuola e a divenire responsabile, per la Camera del Lavoro di Modena, dei “corsi delle 150 ore” che erano previsti dal contratto dei metalmeccanici prima e successivamente da altre categorie per consentire il ritorno sui banchi e il completamento dell’obbligo alla gran massa dei lavoratori che ne era priva”.
Promotrice del doposcuola e del Comitato di quartiere del centro storico di Modena, attiva partecipante nella costituzione di Cgil Scuola, ma anche componente di gruppi femministi modenesi. Quali erano le motivazioni che all’epoca ti portarono a aderire al movimento femminista?
“Ho aderito al femminismo non immediatamente, ma a metà degli anni ’70, spinta soprattutto dagli avvenimenti legati al referendum sul divorzio e alla mobilitazione sui consultori e sulla questione dell’aborto. Qualcosa mi mancava, sentivo la necessità di andare oltre i vari aspetti della militanza politico-sindacale per approfondire un percorso “interno” che desse spazio alla mia soggettività nelle relazioni con gli altri e le altre. Era riconoscere una parte di sé fino ad allora in ombra ma che si rivelava nel rapporto con le altre compagne del collettivo. Declinai poi il mio femminismo anche dentro il sindacato, dando vita all’intercategoriale donne – impensabile per la Cgil che lavoratrici delle diverse categorie si riunissero da sole e avanzassero richieste ai dirigenti, ma così fu! Quasi una rivoluzione– e ai seminari “150 ore” sulla salute riproduttiva in cui per la prima volta le lavoratrici osavano raccontare i problemi fisici e le discriminazioni che vivevano sul luogo di lavoro e le difficoltà di svolgere contemporaneamente i compiti familiari: oggi diremmo che si fece un’analisi gender oriented della condizione di vita delle lavoratrici, e si formò una grande solidarietà tra tutte, riconoscendosi le une nelle vite delle altre”.
Nel 1980 nasce la Cooperativa Le Nove, di cui sei una delle fondatrici. Si tratta di un gruppo di donne, con professionalità diverse, che sonda le trasformazioni delle soggettività nei processi di mutamento della società italiana alla luce della differenza di genere. La pratica femminista si istituzionalizza in una attività professionale?
“Non è un caso che la cooperativa delle donne Le Nove nasca nel 1980, quando era cominciata la fase “culturale” del movimento femminista che, ritirandosi dalle piazze in concomitanza degli anni di piombo, diede vita a centri donna, gruppi di studio universitari e non, associazioni di storiche, di architette e altre professioniste che sentivano il bisogno da una parte di fare emergere la presenza femminile che per secoli era stata cancellata, dall’altra di guardare alla società contemporanea con occhi nuovi, analizzare la condizione delle donne mettendone in luce differenze e similitudini rispetto a forme di subalternità e aspirazioni, all’intreccio fra dimensione privata e pubblica, al peso dei ruoli sociali e all’ambivalenza nelle relazioni intime. Con amiche già compagne di altri anni di militanza, nacque il progetto di una cooperativa di ricerca in ambito storico e sociale che ponesse al centro la conoscenza delle trasformazioni delle soggettività delle donne, dal mercato del lavoro ai modelli di famiglia, dalla contraccezione all’organizzazione dei servizi e degli orari della città, ecc. Come ricercatrici lo sguardo non era neutro, ma era in gioco la nostra stessa soggettività nell’interrogare il vissuto delle altre donne e nell’analizzare le loro parole. Sentivamo che le nostre ricerche erano un’altra forma di partecipazione al femminismo, dare visibilità alla voce delle donne e alle loro differenze era anche questa militanza. La nostra vita professionale nel lavoro di LeNove negli anni ha accompagnato l’evolversi, sul piano politico istituzionale, delle politiche di pari opportunità che avevano necessità di essere supportate da precise conoscenze dei problemi del variegato mondo femminile che si andavano ad affrontare, sia sul piano locale che nazionale”.
La Coop Le Nove spaziato con la propria attività in vari campi, dalla violenza di genere, ai percorsi di carriera e ai differenziali retributivi delle donne, dai processi di riproduzione sociale alle trasformazioni identitarie. Anche le politiche temporali vi hanno visto impegnate a fianco di tanti Comuni negli anni 90, in particolare. Ti sembra che oggi ci sia ancora centralità delle politiche temporali per gli enti locali?
“Credo che le politiche temporali che hanno riguardato l’organizzazione della città siano state veramente innovative negli anni 90, quando si riuscì, attraverso un articolo di legge che assegnava al sindaco la prerogativa di “armonizzare” gli orari dei servizi, a porre al centro dell’attenzione (e della politica) la questione del tempo quotidiano e di come le donne lo vivono nella successione faticosa degli impegni propri e per gli altri soggetti della famiglia. Quella stagione, che chiedeva alla politica di modificare l’organizzazione dei servizi pubblici (e anche privati ), aveva bisogno di creare un ecosistema favorevole nel quale interagissero il pubblico e il privato per migliorare e semplificare l’accesso ai molti servizi che si integrano con la vita familiare, per “liberare” tempo, per consentire alle donne di avere, si diceva, tempo per sé. Le ricerche mostravano in modo lampante come fosse differente l’uso del tempo fra donne e uomini. Molti cambiamenti sono in effetti avvenuti – ad esempio gli orari degli uffici della pubblica amministrazione con aperture più lunghe, maggiore flessibilità negli orari dei servizi all’infanzia, ecc. – anche nella fase successiva che venne declinata (per effetto delle politiche dell’UE) come “conciliazione fra la vita lavorativa e quella familiare”. Ma gli enti locali non trovarono alcuna condivisione nelle imprese private che regolano il tempo lavorativo; furono poche le imprese time oriented che sperimentavano buone prassi in orari di lavoro rispondenti alle richieste delle lavoratrici, e solo recentemente, per effetto della pandemia, sono state prese in considerazione proposte che non avevano avuto diffusione significativa: il lavoro agile, l’ingresso differenziato nelle scuole per allentare il traffico, le aperture differenziate dei negozi…Questo per dire che l’organizzazione temporale della città necessita di una costante revisione per adattarsi alla società che cambia e ai nuovi bisogni dei cittadini a cominciare dalle lavoratrici; soprattutto rimane ancora irrisolto il problema degli orari di lavoro e di una loro flessibilità “positiva”, visto che la maggior parte delle lavoratrici che si licenziano dopo la maternità lo fa per difficoltà di conciliare i tempi familiari con la rigidità degli orari di lavoro. E c’è da aggiungere che le politiche temporali hanno anche fatto emergere la necessità di condivisione con l’uomo nei compiti e nei tempi familiari: gli enti locali hanno spazio per dare supporto a queste necessità di condivisione promuovendo specifici interventi di riflessione, ad esempio, nella gestione dei servizi per l’infanzia”.
Tra le tue esperienze c’è anche un periodo dedicato all’attività istituzionale come consigliera all’interno della Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. La giudichi positiva?
“È stato un periodo ricco di conoscenze per me che non avevo mai avuto un’esperienza istituzionale, facevo parte della commissione cultura e formazione professionale. L’ottica regionale, quel suo essere snodo fra l’amministrazione centrale e i territori consente di avere una visione articolata e non scontata dei problemi e delle possibili soluzioni. Che possono essere molto innovative. Cito ad esempio la legislazione che ha regolato il “sistema teatrale“ dell’Emilia-Romagna e di come risulti necessario, indispensabile, la interlocuzione con i diversi soggetti, teatri, compagnie, ecc., radicati sui territori. Rispondere alle istanze che provengono dalla società nelle sue diverse espressioni. Oppure mettere mano alle norme relative alla diffusione e organizzazione degli asili nido la cui presenza consente alle donne di fruire di opportunità di lavoro o sostenere la nascita e la diffusione dei centri antiviolenza. Capisci che la Regione può fare una buona politica, dare indirizzi e prendere decisioni i cui effetti positivi poi ricadono sulle comunità, sulle persone e il loro benessere (o viceversa). Ecco, quello che ho più apprezzato e da cui molto ho imparato, è stato partecipare al processo di formazione di una legge nelle diverse fasi, dalle audizioni dei soggetti interessati alla scrittura e riscrittura dell’articolato di legge, che non può essere ambiguo nelle sue formulazioni”.
Ormai quasi dieci anni fa, in collaborazione con Alessandra Bozzoli e Maria Grazia Ruggerini hai scritto “Il lato oscuro degli uomini”. Il volume è una preziosa mappatura di quello che nel privato e nel pubblico all’epoca si era fatto in termini di azioni e luoghi di accoglienza degli uomini violenti in Italia. Credi che sia chiara oggi la necessità di focalizzarsi, da parte dei decisori politici, anche sulla “questione maschile” che è sottesa alla violenza di genere, affinché riconosciuto e contrastato il fenomeno, anche dal punto di vista culturale, si interrompa la trasmissione alle giovani generazioni?
“Constato che negli ultimi dieci anni si sono fatti dei passi avanti nel comprendere il fenomeno della violenza e la responsabilità di chi la esercita: i servizi per uomini maltrattanti lo stanno a dimostrare. I centri per il recupero dei maltrattanti sono cresciuti di numero, dal primo censimento che facemmo, gestiti da associazioni del privato sociale e dal pubblico. Qui in Emilia-Romagna ce ne sono 15, sette pubblici gestiti dalle ASL e gli altri privati. La consapevolezza della “questione maschile” ha riscontri anche in aspetti legislativi nazionali, tuttavia rischia ogni momento di essere dimenticata quando certe espressioni mediatiche tendono a sminuire la responsabilità dell’autore, a trovare minimizzazioni. Perché troppo diffusa e forte è ancora la cultura che legittima le condizioni di potere e di controllo dell’uomo sulla donna. È su questo che bisogna lavorare, per una concezione più egualitaria e meno stereotipata degli uomini e delle donne, dei loro ruoli sociali. La scuola ha una grande responsabilità in questo processo, perché è sulle generazioni giovani che occorre fare leva per un cambiamento di modelli culturali profondamente interiorizzati nella nostra società mediterranea. E non tutti i segnali sono positivi. Diverse ricerche condotte in scuole superiori anche della nostra regione mostrano in molti maschi giovani la persistenza di una concezione di forte subalternità e di possesso dell’altro genere, e non sempre fiducia nelle proprie capacità ma bisognose di protezione in una parte delle ragazze. È questo il terreno su cui bisogna lavorare, non c’è altra strada”.
Presidente di ERT- Emilia-Romagna Teatro, Vicepresidente di Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, fino al 2017: dal tuo lungo e apprezzato impegno in queste due realtà culturali si può dedurre che consideri il teatro, prosa o danza che sia, un “fertilizzante” necessario della vita democratica?
“Mi piace l’immagine del teatro che “fertilizza” la vita democratica. Il teatro nelle sue diverse espressioni ha bisogno di spazi di libertà per esistere e per creare una relazione di pensiero e di emozioni con i cittadini. Direi che è necessario il teatro, come si è potuto constatare nei mesi scorsi, quando l’epidemia ne ha costretto la chiusura facendone sentire terribilmente la mancanza; necessario perché ci mette di fronte a noi stessi e alle nostre convinzioni, ci spiazza chiedendoci di andare più a fondo nelle idee e nei sentimenti, oltre la superficie delle cose, così come ci affascina l’espressività e la bellezza dei corpi. Necessario al nutrimento dell’anima, dunque il teatro, anche se l’espressione può apparire retorica. E le due istituzioni teatrali che per diversi anni ho accompagnato con grande passione personale nella loro attività incarnano – nella diversità dei linguaggi artistici di ERT e di Aterballetto – questa pratica di bellezza, di creatività, di libertà”.
Natalia Maramotti
La biografia di Maria Merelli
Negli anni Sessanta la sua formazione politico-culturale inizia al “Centro Vanoni”, associazione fondata dalla “sinistra cattolica modenese” guidata da Ermanno Gorrieri e prosegue con il circolo “Il Portico”. Attraversa i movimenti del Sessantotto e degli anni Settanta come insegnante di lettere nelle scuole superiori modenesi. Nei primi anni Settanta è tra le promotrici del doposcuola e del Comitato di quartiere del centro storico di Modena che svolge un’attività politica di base rivolta agli immigrati meridionali insediati principalmente in questa area della città. Partecipa alla costituzione della Cgil scuola. All’interno del sindacato è attiva nell’organizzazione delle 150 ore. Fa parte dei gruppi femministi modenesi. La sua attività politica prosegue principalmente sul versante culturale. Fondatrice e socia di LeNove dal 1980, è esperta di strategie di genere attuate da istituzioni pubbliche e organismi della società civile a livello nazionale e internazionale e nella costruzione di network fra enti pubblici, privati, governance locale; studiosa delle trasformazioni dell’identità femminile e dei percorsi di empowerment in diversi contesti sociali e nella migrazione, si è dedicata in particolare all’analisi delle politiche temporali urbane, ai sistemi di conciliazione e welfare territoriale, allo studio delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere a livello regionale e nazionale. E’ stata inoltre consigliera della Regione Emilia-Romagna nella V legislatura, Presidente del Teatro Stabile Pubblico (ERT) dell’Emilia-Romagna e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Danza Aterbaletto.