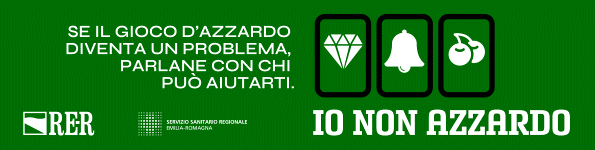REGGIO EMILIA – Anna Kauber nasce architetta, ma se oggi ti voglio descrivere devo allargare il campo dicendo scrittrice, paesaggista regista e femminista. Ci racconti come si tengono insieme i tuoi talenti e identità?
“Forse nasco femminista, più di ogni altra cosa. Nel 1974, portato a casa da mia sorella maggiore, lessi “Noi e il nostro corpo”, uno dei testi fondamentali per la presa di coscienza femminista. Avevo 15 anni e quella lettura mi cambiò per sempre. Già l’anno dopo entravo nel circolo UDI di Parma, nell’importante ruolo strategico di addetta al ciclostile. Nella visione e nella sensibilità femminista, dunque, credo si manifesti più d’ogni altra cosa la mia identità “profonda”, quella che guida e indirizza le mie riflessioni e il modo di vivere nelle relazioni, nel lavoro, nelle analisi e nella progettualità creativa. Ho poi avuto la fortuna di “vibrare” istintivamente alle tante manifestazioni del bello, del vero e del giusto che, se sappiamo cercarle con apertura di mente, di cuore e dei sensi, si manifestano attorno a noi – piccole e grandi, o palesi – come opere dell’uomo o della natura.
Ascoltare, rendendosi permeabili a tutte le suggestioni e le informazioni che ci possono nutrire; studiare, approfondendo con empatia e attenzione, e quindi creare, per trasferire la conoscenza acquisita e restituire quello che si ha ricevuto. Forse allora non è un caso che i miei interessi, i miei studi abbiamo avuto una sorta di “dilatazione” nello spazio (dagli ambienti domestici al paesaggio) e nei contesti umani (dal cliente privato alle comunità), in un percorso individuale che ha sempre attinto al patrimonio di esperienze intellettuali e sensoriali vissute e che oggi, sedimentate profondamente in me, continuano ad arricchire di contenuti – di bellezza e di complessità, di grazia e di problematicità – ogni pensiero o nuovo progetto”.
Vieni da una terra, Parma e la sua provincia, nella quale il segno dell’agricoltura incide sull’economia e sulla società, direi persino sul senso con il quale chi lo abita costruisce la reputazione del proprio territorio. La tua passione per la terra nasce forse da questa cultura; quello che però la rende speciale è il tuo sguardo di genere, che ti ha portato ad indagare sul femminile nel mondo agricolo. Qual è stato il percorso per questo approdo?
“Con i miei fratelli, siamo la prima generazione di parmigiani/emiliani della famiglia. Non so quindi se è stato questo territorio di vocazione e cultura agricola ad avere condizionato il mio innamoramento progressivo e inarrestabile per il paesaggio rurale. Sicuramente, i temi che più mi appassionano sono quelli che contengono un principio di condivisione “globale”, e che quindi, anche attraverso una specifica narrazione contestuale, siano essere in grado di coinvolgere trasversalmente il maggior numero di persone. E il paesaggio rurale italiano, nella sua interezza, include e rimanda a una eccezionale densità di contenuti universali: la biodiversità animale e vegetale, l’ecologia, l’alimentazione, i conflitti e le relazioni sociali, l’economia, la salute e la sostenibilità, le disuguaglianze e i diritti, l’identità, la memoria e il patrimonio materiale e immateriale.
Esperienze che hai tradotto in immagini e testi.
“Sono linguaggi a me congeniali e in grado di promuovere quei processi di avvicinamento alla comprensione empatica, anche dei non addetti ai lavori, attraverso la sollecitazione intellettuale ed emozionale. Il paesaggio rurale è il contenitore naturale delle storie di vita degli uomini e delle donne che, col loro lavoro, lo hanno creato, e oggi lo preservano o lo trasformano, lo curano continuando a renderlo fertile. Queste persone producono cibo e bellezza e garantiscono quei servizi eco-sistemici necessari per un corretto utilizzo delle risorse ambientali. Il lavoro agricolo ha forgiato la forma della terra, e la civiltà contadina ha permeato le culture nel mondo, arricchendole di saperi, di conoscenze, di leggende, di riti, di simboli molti dei quali permangono tutt’ora: cosa c’è di più affascinante di questa epopea universale?”
Ed è apparsa evidente la “via femminile”.
“Tutte le testimonianze raccolte, infatti, mi svelavano lo sguardo particolare delle donne sulla preservazione della vita in tutte le sue forme, e mettevano in evidenza la singolarità dei loro sforzi, le strategie e le modalità specifiche per proteggerla e garantirla ai figli e ai nipoti. Il mondo rurale contemporaneo si stava trasformando grazie a questa visione di genere, ancora poco raccontata e conosciuta. Ero infine agevolata dalla fluidità e immediatezza della relazione fra noi, intervistatrice e intervistata, del rapporto paritario e talvolta anche di sorellanza che si creava nella condivisione di intere giornate di lavoro e di vita domestica, e dalla facilità con cui nascevano fiducia e reciprocità, su cui si riusciva a strutturare un denso linguaggio femminile, vero, diretto e coinvolgente”.

Il tuo “Ritratti di donna e di terra” indaga sulla specificità di genere in agricoltura. Intervistata sul progetto hai affermato: “Da sempre credo che lo sguardo femminile inclusivo del piccolo, dell’inascoltato, dell’intimo sulle cose e sul mondo sia in grado di interpretare la realtà in modo particolarmente completo”. Siamo in una contingenza della storia nella quale pare che anche il nostro Paese, ancora arretrato rispetto alla valorizzazione del femminile, si sia reso conto della necessità di questo sguardo differente che si materializza quotidianamente nei gesti di cura che le donne compiono in modo oblativo, come di un imprescindibile contributo per la ripresa. Pensi che dai tuoi ritratti di donne e di terra si possa ricavare un’argomentazione a sostegno di un’etica che guarda alla cura del mondo, con attenzione al piccolo, all’inascoltato, all’intimo, necessaria per evitarne la depredazione ulteriore e forse il tragico epilogo?
“La felice esperienza di metodo e contenuto iniziata con “Ritratti di donna e di terra” ha segnato la strada che avrei percorso nelle mie ricerche successive: l’indagine di genere che dava voce alle donne impegnate nell’agricoltura aveva dimostrato infatti che la loro specificità di visione e di pratiche lavorative erano portatrici di istanze nuove e feconde per la cura della nostra casa comune. Fra le prime evidenze, confermata con forza sorprendente nella successiva ricerca sulle donne pastore, risultava sicuramente la difesa della vita in tutte le sue espressioni, insieme all’impegno per preservarla viva e vitale, per se stesse, per la propria famiglia e le generazioni dopo di noi. Questo è quello che chiamiamo cura. Lo sguardo femminile, completo in quanto inclusivo del piccolo e del complesso, del privato che è anche comunità, dell’inespresso che sa diventare affermazione, delle memorie come della proiezione sul futuro, promuove e consolida l’alleanza tra essere umano e ambiente. In antitesi, quindi, con l’atteggiamento predatorio delle risorse naturali che sta purtroppo sempre più caratterizzando il mondo contemporaneo. Sono convinta che l’attuale crisi ambientale e morale non possa essere superata tralasciando questa cultura specifica di genere, ma anzi che l’approccio e il pensiero femminile possa contribuire a modificare proprio quel modello di sviluppo che l’ha generata”.
Da alcuni anni si fa un gran parlare di aree interne. Dal dopoguerra ad oggi si è assistito in Italia al loro progressivo spopolamento. Tra i molti effetti negativi di questa trasformazione c’è l’insorgenza di problematiche ed emergenze ambientali derivanti dalla mancanza di vere e proprie azioni conservative del territorio, che sono garantite dalla presenza di chi lo coltiva e lo abita. Tutto questo ha qualche relazione con la tua decisione di fare 17mila km tra Alpi e dorsale Appenninica per raccontare la storia delle pastore, o come qualcuno ha scritto delle “signore degli agnelli”?
“L’oblio – potremmo dire, la rimozione – delle nostre origini rurali nell’arco di un secolo ha trasformato radicalmente l’Italia, il suo territorio e la sua cultura. Anche l’agricoltura è stata investita dal modello di sviluppo che propugnava la retorica del progresso nel mito della crescita illimitata. E così, come il contadino è diventato agricoltore o imprenditore agricolo, anche il pastore è stato sostituito dall’allevatore, sradicato dalla terra e rinchiuso insieme ai suoi animali negli allevamenti industriali. Il costo sociale, ambientale ed economico di questa epocale trasformazione è stato altissimo, le cui conseguenze sono oggi riconosciute fra le più gravi problematiche ed emergenze nazionali. E mentre anche il modello urbano palesa le proprie crescenti difficoltà, fuori dei centri la condizione di vita continua a peggiorare.
Con l’automobile (a metano, per cercare di compiere il lungo viaggio il più green possibile) carica di scarponi e apparecchiatura tecnica, proprio in quanto consapevole dell’importanza di queste grandi tematiche generali in gioco (montagna, ambiente, storia e cultura della pastorizia, approfondite nello studio e nelle letture), ho voluto indagare le motivazioni della scelta controcorrente, coraggiosa e felice di quel piccolo drappello di pace e di cura di donne pastore”.
“In questo mondo”, che ha vinto il premio quale miglior documentario italiano al 36° Torino Film Festival, con la sua poetica, mi ha suggerito una relazione, forse un po’ corsara, con un libro di una filosofa italiana, purtroppo recentemente scomparsa, Elena Pulcini, che ha scritto molto sul tema della cura. Il libro è appunto “La cura del Mondo”. Il mondo è presentato come un insieme plurale di esseri singolari, umani e non. Un gregge è, nella metafora corrente, considerato come una somma di individualità senza soggettività. Nel tuo racconto per parole e immagini l’approccio femminile valorizza la cura del gregge e insieme a questa la tutela della biodiversità, della unicità del paesaggio. Possiamo dire che nelle azioni delle pastore e nella loro relazione con il gregge c’è una metafora delle ragioni della co-appartenenza, che mettono in dubbio l’ossessione dell’io, alimentando l’idea della necessità dei legami sociali e ambientali per salvare il mondo?
“Il film parla di donne, delle più svariate età e provenienze, che hanno fatto la scelta di vivere nel contatto quotidiano con l’aria aperta e con gli animali che allevano e di cui hanno cura, riappropriandosi di uno spazio che la tradizione, l’immaginario e la prassi hanno sempre lasciato a disposizione dell’uomo. Il pastore è maschio, per consuetudine, e quel modello lavorativo è stato fortemente caratterizzato dalla cultura maschile e patriarcale. Eppure il centinaio di figure femminile rintracciate in tutta Italia nei due anni di viaggio, mi ha mostrato una prospettiva nuova, se non completamente differente comunque in grado di ricercare un nuovo rapporto tra umano, animale e ambiente, riscrivendo il tempo di una professione millenaria, tra le più antiche della storia dell’umanità. La via femminile alla pastorizia confuta tale stereotipo e offre una propria visione specifica nuova sia nei presupposti che nelle pratiche”.
Come vi riesce?
“Si basa essenzialmente sulla relazione più rispettosa e, forse, più viscerale col mondo naturale, incardinata sui principi della cura e della sacralità della vita, sulla prossimità col gregge, sull’affettività e l’empatia; e si struttura nell’allevare secondo un approccio diverso, antitetico a quel modello industriale di sfruttamento predatorio di animali e di risorse che, nei decenni, ha purtroppo causato spaventosi danni ambientali, unitamente alla perdita di tanta biodiversità, impoverimento dei saperi tradizionali e distruzione dei meravigliosi paesaggi italiani. La vita da pastore è più difficile di quanto si possa immaginare, giocata sul fragile equilibro fra il risultato economico e la fatica di un mestiere territorio difficile, aspro, con pochi servizi e semi-abbandonato. Conoscerle è stato per me un’esortazione alla resistenza, al coraggio di restare, di rilanciare sempre riuscendo a non soccombere a una burocrazia barocca, inutilmente vessatoria, al disvalore attribuito al loro lavoro, alla concorrenza dei prezzi della grande distribuzione (sebbene non paragonabile per qualità e sicurezza alimentare), ai continui disagi e all’ennesimo attacco del lupo. La sola passione non basta: la loro scelta si riferisce a un differente apparato di valori generali, con altre priorità e nuovi bisogni personali e di relazioni di comunità. Sono sicura che il contatto diretto con la natura e la capacità di amarne ogni singolo aspetto e manifestazione, i legami di solidarietà e scambio con le piccole comunità residuali, l’empatia e la “sorellanza” del modello di esistenza delle donne pastore rappresentino per loro un principio di libertà individuale potentissimo, portatore di una grande felicità interiore”.
L’Anna Kauber che conosciamo a quale genealogia femminile, se ce n’è una, deve, almeno in parte, ciò che è diventata?
“Ho riflettuto molto su questa domanda, indecisa se rendere pubblica la prima risposta che mi era venuta in mente. Ma lo faccio, nonostante non sia per niente semplice a causa del mio enorme coinvolgimento emotivo. Ho infatti pensato immediatamente a Paola, la sorella maggiore, e al breve percorso di vita che abbiamo potuto condividere, e all’esperienza dolorosa della sua lunga malattia e della morte che ci ha definitivamente separato. Aveva sei anni più di me, e a diciotto le hanno scoperto una malattia rarissima e inguaribile che, dopo dieci anni, l’ha fatta morire. Aveva ventotto anni. Paola era la sorella che aveva portato a casa “Noi e il nostro corpo”, i Beatles e Fabrizio De Andrè, le innumerevoli attività di artigianato folle e creativo, la contestazione contro i genitori e tutto il sistema (che anni!), le istanze di emancipazione femminista, la rivendicazione della sessualità libera e della parità di genere… Il tutto, in un turbine di intelligenza e vivacità ricco di informazioni, idee vertiginose, contestazioni senza esclusione di colpi, insicurezze malcelate, alternanze sorprendenti di allegria e scoraggiamenti, progetti e avventure permesse o rubate. Nonostante il suo calvario straziante e benché conoscesse perfettamente il suo destino, Paola ha combattuto fino in fondo, con una dignità unica e con un coraggio che, con la maturità, ho imparato a riconoscere come veramente eccezionale. Durante la malattia, è riuscita a laurearsi e, finché ha potuto, ha cercato di condurre una vita normale, senza mai, davvero mai lamentarsi o commiserarsi. A lei, a questa amatissima sorella, io e i mei fratelli dobbiamo tantissimo: la consapevolezza della perdita e del distacco ha saldato il nostro amore, ci ha reso più forti e, a nostra volta, coraggiosi. Assistere per dieci anni al progressivo spegnersi della sua vita ha condizionato il mio sviluppo, forgiando il mio carattere. La sua faticosa lotta per sopravvivere ha tracciato per sempre la strada, facendomi capire quale fosse la vera gerarchia dei bisogni e dei valori, e su quali riferimenti morali e priorità dovessi concentrare la mia ricerca.
Sono enormemente grata a mia madre, che sebbene immersa nel dolore di assistere, impotente, alla lenta agonia della figlia, non ha mai ceduto alla disperazione (almeno non davanti a noi figli), ma anzi è riuscita sempre mantenere salda e viva, e se possibile anche ottimista e allegra, l’atmosfera familiare. Madre coraggio, dunque: ma a completare l’elenco dei riferimenti fondativi della mia personalità c’è anche una zia, sorella di mio padre. Nonostante tutta la loro angoscia impotente, queste tre donne della mia famiglia – Paola, la mamma e la zia Ilse – sono riuscite a mantenere aperto il cuore e lo sguardo alle esigenze di noi altri fratelli/figli/nipoti. Devo principalmente a loro ciò che sono: ho vissuto assorbendo questo esempio di coraggio quasi sovrumano, contemplando la loro infinita capacità di dare amore, continuando ad ascoltare e accudire, anche nello strazio della certezza della morte”.
Natalia Maramotti
Chi è Anna Kauber
Nata a Parma, dove vive, il 3 febbraio 1959. Regista, scrittrice e paesaggista. Da anni documenta e divulga la vita e il lavoro nel mondo rurale, occupandosi in particolare di tematiche sociali e culturali delle comunità. Nel 2014 pubblica il libro “Le vie dei campi”, che vince il Premio di letteratura rurale “Parole di Terra”. Nel 2015 conclude la raccolta di video-interviste “Ritratti di donna e di terra” che ricerca e documenta la specificità di genere in agricoltura.
Nel 2017 le viene assegnato il premio “Garganello d’oro per la promozione della cultura del cibo”.
Dal 2015 al 2017 intraprende un viaggio di circa di circa 17mila km e di 100 video interviste rivolte a donne pastore di età compresa tra i 20 e i 102 anni, che descrivono un modo differente di intendere la vita stessa, i suoi ritmi e i suoi valori.
Nato dal suo progetto “Tre montagne per tre pecore”, nel 2017 viene ratificato il protocollo di intesa del “Gemellaggio delle 3 pecore”. Sotto l’egida del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, i Comuni di Corniglio (Parma), Lamon (Belluno) e Valgrisenche (Aosta) si uniscono per il recupero e la salvaguardia delle proprie razze ovine autoctone, in pericolo di estinzione
Dalla ricerca sulle donne pastore è stato realizzato il film “In Questo Mondo”, miglior documentario italiano al 36° Torino Film Festival.
Nel 2018 riceve il Premio Speciale Pontremoli di Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) “Cultura della montagna”.
Nel 2019 Legambiente Italia le conferisce il premio “Ambasciatrici del Territorio”: è premiata al Cook Awards del Corriere della Sera, nella categoria “Food Reporting”.